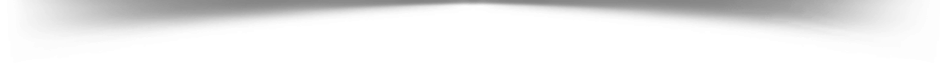Il giorno dei vivi
- DATE 2 Nov , 2016
- Author: sara
- COMMENTS Leave a comment
Dialogo tra A., quattro anni e mezzo, e Davide, cinque anni e mezzo.
A.: “Ma cos’è la tomba?”
Davide “E’ dove ti mettono dopo che ti hanno fatto il funerale.”
A.:“ E che cos’è il funerale?”
Davide (con aria da professore un po’ scocciato): “Allora, quando muori, ti mettono dentro uno scaffale, no aspetta, un armadio. Poi ti fanno il funerale, dove tutti dicono qualcosa di bello su di te. Poi ti mettono dentro la terra oppure ti bruciano. E poi basta, ecco fatto. Tanto prima o poi tocca a tutti. E poi c’è della gente nuova che nasce.”
A.: “ e quindi quando muori ti mettono nella tromba?”
Davide: “TOMBA!”
L’esilarante e quanto mai veritiera conversazione è avvenuta qualche giorno fa, dandomi nuovi spunti sul tema morte, e sulla facilità con cui i bambini affrontano invece gli argomenti che per noi sono tabù.
La spiritualità non è di casa nella nostra famiglia: Davide non è battezzato e io, nonostante la forte presenza della cultura da cui proviene il papà di Davide, resto pragmatica nelle spiegazioni dei massimi sistemi.
Non amo andar per cimiteri – a meno che non si tratti di Staglieno, dove mi perdevo ventenne dopo aver reso omaggio a De André, oppure di Père-Lachaise – e non ho trasmesso questa tradizione a Davide, forse sbagliando non so.
Da bambina ogni anno, il 1 novembre era sacro, il momento per andare a rendere omaggio a bisnonni mai conosciuti, ed ascoltare storie di famiglia con gioia.
Oggi ho solo una persona cara sepolta, mia nonna, ed in tre anni sono riuscita ad andare al cimitero una volta sola.
Detesto l’odore dei fiori marci, i passi che rimbombano in silenzio e non mi sento in nessuna sintonia con quel luogo. Resto imbambolata di fronte alla tomba, guardando la foto che la ritrae nei suoi giorni migliori, quelli in cui l’ho conosciuta davvero e mi sale solo una gran tristezza.
Non è quello il modo di celebrarne il ricordo, né il luogo adatto.
Lei, come le poche altre persone più o meno care perdute, amici per lo più, vivono ogni giorno, ogni volta che li penso.
Lei vive nella sua sciarpa, che indosso in inverno.
Nella sua ricetta delle polpette.
Nel sapore del sugo, che non sono mai più riuscita a riprodurre.
Nell’odore di bruciato che mi riporta ai miei autunni precoci passati in pianura padana.
E poi c’è M. che ricordo ogni volta che mi si blocca la lavastoviglie, perché mi ha insegnato lui come sbloccarla.
Oppure quando penso che aveva voglia di fare l’amore con me anche quando avevo addosso il tutore e la spalla lussata.
Lo penso quando assaggio la focaccia del panificio sotto la mia vecchia casa, con cui lui si presentava puntualmente all’una di notte.
E sorrido, sapendo che finché me lo porto nel cuore non morirà mai davvero.
La mia nonna paterna rivive ogni volta che sento lo zucchero delle uova sbattute sciogliersi sulla lingua, mentre del mio nonno paterno ricordo solo lo sguardo severo e le critiche alla mia linea che più di una volta mia hanno ferita in adolescenza.
L., morto suicida, rivive ogni volta che ripercorro le tappe dell’inter-rail fatto insieme. O quando vedo volare un aereo, che lui sapeva pilotare.
Questo resta di noi, negli anni, nelle persone.
I piccoli gesti, le attenzioni, le manie, le abitudini… tutto quello che fanno di noi le persone che siamo in realtà.
Tutto quello che resterà a chi ci ha conosciuto davvero.
Più di qualsiasi epitaffio.
“Faceva polpette da urlo”.
Non sarebbe meglio di “madre e moglie devota”?
Secondo me sì.
Ma scrivetemelo sulla tromba, dopo avermi chiuso nell’armadio, per carità.
- Tagged:
- POSTED IN Blog
- fiducia
- musica
- vita da single
- vita
- 8 marzo
- Guerra
- Inverno
- winter
- Torino
- immigrazione
- Salone del libro
- burian
- frozen
- freddo
- Collaborazioni
- figli
- Pilates
- Bullismo
- Sport
- Benessere
- Ghost
- Film
- Alluvione
- Halloween
- Anni '90
- Moda
- Parigi
- Nonna
- Mostre
- discr
- violenza
- 25 Novembre
- andrà
- valigie
- gabbia
- camminare
- il corpo del
- G8
- incipit
- partenze
- tiger
- ridere
- decathlon
- dormire
- inizi
- fine
- mestruazioni
- love
- 11 settembre
- relaz
- rivoluzione
- politica
- social
- Gli invisibili
- aborto
- festa del papà
- black lives matter
- gabbiere
- felicità
- happinessa
- andràtuttobene
- Immuni
- Buenos Aires
- Migranti
- Letture
- maschere
- Serie TV
- Settembre
- Blog
- Ricordi
- amicizia
- Storie di Donne
- pregiudizi
- Pubblicità
- san Valentino
- Amsterdam
- Diritti
- paura
- ragazzi
- inaugurazione
- mare
- il corpo delle donne
- Ponte San Giorgio
- femminismo
- Ballate
- New York
- Anno Nuovo
- Libri
- Figli senza diritti
- Bellezza
- scrittura
- travelling
- lockdwon
- pride
- Morte
- Natale
- Famiglie arcobaleno
- DAD
- Gender
- Attualità
- Tempo
- Arte
- Racconti
- Ponte Morandi
- omofobia
- razzismo
- Vacanze
- monamour
- scuola
- covid
- Famiglia
- Genova
- Estate
- omosessualità
- lockdown
- Viaggi
- A come amiche
- Bambini
- Donne
- coronavirus
- quarantena
- D come donna
- Discriminazione
- Amore
- Maternità
- Lifestyle
- Relazioni